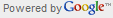Insegnamento e testimonianza di Giuseppe Toniolo «credente radicale» di Francesco Occhetta - 21 aprile 2012
Anticipiamo stralci di uno dei saggi pubblicati sul numero in uscita de «La Civiltà Cattolica»
| La dottrina sociale della Chiesa elaborata nel Novecento e l'idea di democrazia su cui si basa la Costituzione italiana, promossa da molti esponenti cattolici, portano le tracce dell'insegnamento e della testimonianza di Giuseppe Toniolo. Del professore veneto è stato scritto quasi tutto, edulcorando spesso passaggi del suo pensiero o della sua vita che oggi potrebbero sembrare anacronistici o semplicemente datati. Invece, proprio per essere stato «uomo del suo tempo» e un «credente radicale», la Chiesa lo proclamerà beato il 29 aprile nella basilica di San Paolo a Roma.
La sua testimonianza, vissuta in tutte le dimensioni della vita (spirituale, familiare, professionale, sociale e politica), lascia al laicato cattolico almeno due grandi insegnamenti: non avere paura di essere testimoni credibili e creduti del proprio tempo, nonostante il rischio ‹ come lo è stato per Toniolo ‹ di essere frainteso dalla gerarchia ecclesiastica e deriso dai propri colleghi, molti dei quali legati alla massoneria; non arrendersi, nelle contraddizioni della storia che spesso colpiscono la Chiesa e il suo messaggio di salvezza, ma essere «pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi» (1 Pietro, 3, 15). Nel suo agire politico Toniolo contribuisce a focalizzare la questione sociale della sua epoca e aiuta la Chiesa a preparare il terreno per la prima enciclica sociale, la Rerum novarum di Leone XIII. Per elaborare la sua proposta, egli interpreta il contesto in cui vive: è il tempo in cui l'Italia si sta unificando, e i rapporti tra Chiesa e Stato sono tesi. Toniolo svolge la sua attività in due periodi politici molto diversi tra loro. Il primo è quello della depressione economica (1873-1895), delle crisi agrarie e degli sbalzi di accumulazione di capitale. Sono gli anni in cui si alternano i governi anticlericali di Crispi e Depretis. Nel secondo periodo, l'Italia cresce economicamente e il governo liberale di Giolitti introduce l'autogoverno del mercato e la crescita dei movimenti sindacali e politico-sociali delle classi operaie e contadine. Tuttavia sono pochi gli studiosi che denunciano il costo umano del progresso che gli operai stanno pagando. Così Toniolo prende a cuore la «questione operaia» e ne fa uno dei temi delle sue lezioni. Le rivoluzioni del 1848 e del 1871 (la Comune di Parigi), gli scioperi e le sommosse che si verificano in molti Paesi fanno prendere coscienza a Toniolo che la Chiesa deve orientare il suo aiuto alle fasce più deboli e meno tutelate, puntando sul ruolo sociale (scuole, ospedali, mense) e morale del suo messaggio. Leggendo i suoi scritti, non ci si deve meravigliare se il suo pensiero è quello di un conservatore ‹ sulle «tesi» in materia dottrinale egli non transige ‹ ma nel campo delle sue applicazioni formula «ipotesi» di grande apertura e valore. Nel 1886, per esempio, scrive sulla rivista dell'Opera dei Congressi il suo «programma sociale di ispirazione cattolica», proponendo ai cattolici italiani di rinnovare il loro impegno nel sociale a partire da un triplice progetto: fondare un'associazione, una rivista e una scuola. L'associazione l'Unione Cattolica per gli Studi Sociali si costituirà il 29 dicembre 1889; la «Rivista internazionale di Scienze Sociali» nascerà nel gennaio 1893, grazie all'appoggio del Papa e del cardinale Rampolla. Toniolo non vedrà nascere la scuola, ma la sua intuizione aiuterà padre Gemelli a fondare la Cattolica. Il vero fine di questo programma sociale non era solamente, come è stato scritto, cristianizzare il Paese a partire dalla rielaborazione dell'enciclica Immortale Dei (1885) di Leone XIII, da cui emergevano sia il valore sociale del Vangelo sia l'invito ai cattolici a impegnarsi nella vita pubblica. Questo aspetto sarebbe riduttivo, se non si capisse che Toniolo vuole creare una democrazia nutrita da radici cristiane, che, in un saggio del 1897 sulla «Rivista internazionale», egli definisce «democrazia cristiana».
La definizione che egli dà di democrazia è attuale e moderna: Tra gli anni 1850 e 1870 Toniolo elabora un'alternativa al sistema, proponendo un modello di «cristianesimo di contrapposizione», che, invece di protestare (e di ragioni contro lo Stato liberale che stava umiliando la presenza della Chiesa e opprimendo le classi povere ne esistevano molte) facesse proposte nuove. Il suo approccio ermeneutico ha alla base una precisa concezione del tempo e il fine della storia, che egli considera ciclica. Crede in un ritorno della storia cristiana: il medioevo era stato il tempo della massima integrazione tra società e Chiesa; l'umanesimo e il periodo della Riforma il tempo della massima divisione. Toniolo voleva cristianizzare la società a partire dagli stessi elementi presenti nel tempo medievale. Lo rivelano i suoi scritti in cui l'autentica «economia capitalistica umana» è stata quella del medioevo, quando, grazie a tre barriere poste dalla Chiesa (condanna del prestito a interesse, proibizione del monopolio e limiti al commercio di speculazione) le classi produttrici agivano tenendo al centro della produzione la persona. La soluzione non era dunque quella socialista: «Nulla noi dimandiamo al socialismo dottrinale, che sotto maschera di emancipazione prepara un più crudele e universale servaggio (...); esso è distruttore, noi vogliamo ricostruire l'ordine gerarchico e per esso la libertà legittima, l'eguaglianza proporzionale, la solidarietà». Il cardinale Rampolla condivideva il progetto di Toniolo, che includeva la fondazione di una nuova «scienza sociologica», per favorire una società più giusta e aiutare i ceti popolari attraverso la perequazione fiscale, la tutela dei contratti di lavoro, l'estensione di adeguati poteri agli enti locali, l'introduzione di un sistema di partecipazione diretta analogo ai referendum comunali svizzeri. Inoltre raccomandava l'istruzione agraria popolare e il miglioramento delle case coloniche. Tutto questo lo possiamo definire «una cultura al servizio degli ultimi», che si oppone alla «non cultura» e integra il servizio diretto agli ultimi. Nell'età della maturità, Toniolo abbandona sia il cattolicesimo intransigente dell'epoca, che considerava i mali della storia come una sorta di castigo per le colpe degli uomini, sia una testimonianza militante molto rigorosa e dura, che gli impedisce di interloquire con esponenti di altre culture. Con uno slogan, potremmo dire che negli scritti di Toniolo non c'è etica senza antropologia, altrimenti la sua proposta sarebbe una variante dello Stato etico già teorizzato da Hegel. Non era l'imposizione di leggi, ma l'esigenza di «un modo di stare» nella storia: «Noi credenti sentiamo, nel fondo dell'anima ‹ scrisse nel suo saggio Indirizzi e concetti sociali ‹ che chi definitivamente recherà a salvamento la società presente non sarà un diplomatico, un dotto, un eroe, bensì un santo, anzi una società di santi».
Toniolo non vedrà i frutti della sua semina, anzi ne conoscerà le sconfitte; alla fine della sua vita il mondo cattolico italiano, invece di rilanciare le prospettive sociali democratico-cristiane, si allea con i liberali e, con il Patto Gentiloni, la credibilità del progetto sociale fallisce. Ci sono però due semi gettati dal Toniolo nella cultura cattolica che continuano a dare molto frutto: la creazione delle Settimane sociali dei cattolici italiani e l'intuizione di una università cattolica. Le prime nascono nel Argomenti su cui si gioca la presenza dei cattolici nel mondo, nei temi della vita e famiglia, lavoro e partecipazione politica, libertà e relazione, società e rappresentanza. Inoltre, dopo molta fatica nei decenni passati, stanno ritornando attive le scuole politiche dedicate al Toniolo, in cui, oltre ai contenuti, si devono curare anche il metodo e l'attenzione al territorio. La seconda eredità è l'intuizione che Toniolo sviluppa in un saggio del 1900, proponendo la nascita di un'università cattolica e spiegando le condizioni per la sua realizzazione. Quando padre Gemelli, il 9 settembre 1918, gli comunica la futura nascita dell'università, «l'infermo ha un lampo negli occhi». Le due intuizioni hanno ancora oggi una forte potenzialità per la Chiesa in Italia e la cultura del Paese, ma il laicato ha la responsabilità di far ritornare le Settimane sociali veri momenti di formazione e di presa di posizioni su temi specifici (pace, contratti di lavoro, riforme costituzionali, proposte concrete sulla famiglia), mentre l'Università Cattolica deve distinguersi per la qualità del sapere e la trasparenza dell'agire: pensiamo, ad esempio, ai concorsi, alla scelta dei programmi, di una cultura al servizio degli ultimi. In occasione della sua beatificazione, ricordiamo Toniolo come hanno fatto gli scrittori gesuiti nostri predecessori, che nel 1925 lo definirono con le sue stesse parole: «È uno di quegli uomini più completi, che sanno congiungere la integrità della fede più viva col senso più giusto delle esigenze moderne, e che pertanto sono destinati ad esercitare una salutare influenza per la soluzione non solo delle questioni sociali e di democrazia, ma di questa crisi di intelletti e di coscienze che ci travaglia». Toniolo ha coltivato lungo il corso della sua vita il desiderio di farsi santo. Ancora oggi, per quanti vivono in Dio, si impegnano nel sociale in favore del bene e lasciano una traccia di amore nel cuore di coloro che incontrano è possibile diventare santi, come lo è stato per Toniolo. |